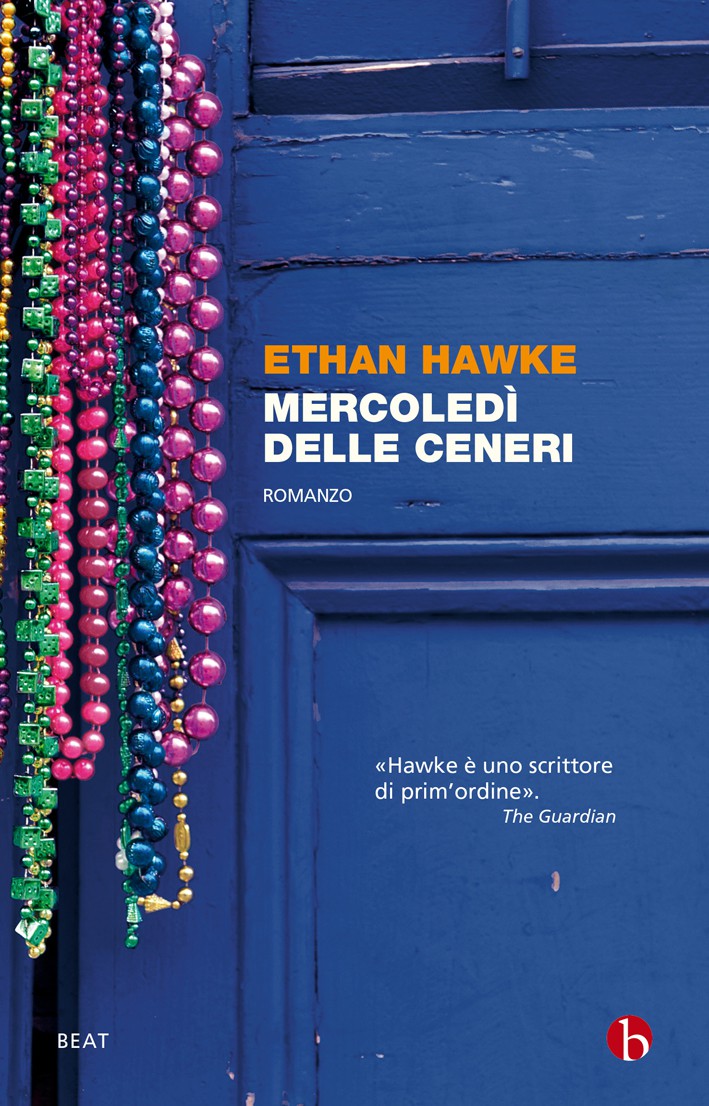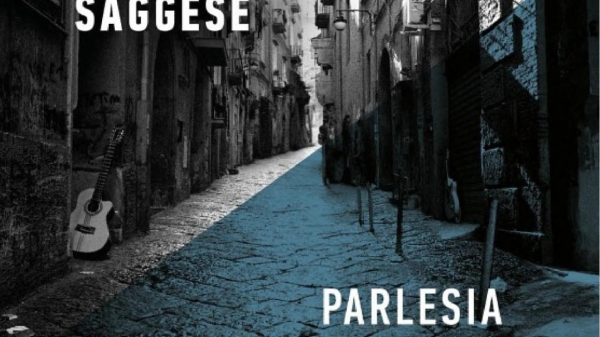Il figlicidio non è solo un atto di natura patologica e la nostra società non è nuova a queste vicende. L’essere madre porta con sé, accanto alla gioia, molte angosce, paure, difficoltà, rabbia, insofferenza, che le donne da sole non sempre possono affrontare, soprattutto quando questi sentimenti diventano insormontabili, arrivando a travolgerle. Perché queste donne sono spesso lasciate sole nelle loro paure, nonostante siano nella maggior parte dei casi circondate da familiari o da mariti, che pur essendoci in realtà non sono presenti affettivamente. Nessun crimine come l’omicidio di un figlio da parte della propria madre ci lascia così inermi. Di fronte a fatti come questi la domanda che nasce spontanea in ognuno di noi è: come può una madre riuscire ad uccidere un figlio? Quali sono i motivi che la spingono a compiere questo orribile gesto? La risposta che tranquillizza la società di fronte a certi casi è senza dubbio quella di attribuire alle madri una patologia mentale, giustificando il gesto come pazzia, perché non è normale che una madre abbia il desiderio di uccidere il proprio bambino. Attribuire questo gesto alla follia ha uno scopo rassicurante, sia perché funge da spiegazione, sia perché allontana da noi l’ipotesi di poterlo commettere in quanto soggetti sani. Questi fatti evocano nella memoria la nostra infanzia, quando avevamo paura della rabbia dei nostri genitori, domandandoci oggi se le nostre madri possono aver avuto l’intenzione o il solo pensiero di ucciderci in quei momenti, di farci del male o d’abbandonarci; per i genitori, rievocano invece episodi della vita in cui si sono sentiti così arrabbiati nei confronti dei figli tanto che la loro reazione è andata oltre i limiti consueti, accettati, spaventati dalla capacità di tale violenza, mai conosciuta prima. Nel profondo della mente di padri e madri si insinua un pensiero pericoloso e segreto che riguarda la paura che possano anche loro, prima o poi, commettere un atto impulsivo nei confronti del proprio bambino. A volte, però, la patologia non sta solamente nella persona, ma anche nell’ambiente familiare e nelle sue dinamiche, una sorta di disturbo relazionale. Può quindi accadere che un soggetto con tale disturbo se osservato da solo non riveli nulla di patologico. È il modo con cui alcune persone interagiscono all’interno di specifiche relazioni che può risultare disturbato, con modalità del tutto simili a quelle che caratterizzano la malattia mentale. Eppure, il figlicidio non è solo un atto di natura patologica, non sempre deriva da una mano dominata da allucinazioni e deliri psicotici e la nostra società non è nuova a queste vicende. Una definizione dei termini usati dalla letteratura è di fondamentale importanza per essere consapevoli di cosa intendiamo con la parola figlicidio, rispetto alla parola neonaticidio e infanticidio. Il diritto distingue solamente tra infanticidio e omicidio. Si parla di infanticidio, quando l’uccisione del feto avviene durante o dopo il parto, in condizioni di abbandono materiale e morale. Al contrario si parla di omicidio, in particolare quando un genitore, non necessariamente la madre, uccide il figlio che può essere anche un neonato, e che spesso risultano di difficile individuazione. La criminologia, rispetto alla giurisprudenza, fa una distinzione sulla base dell’età della vittima. L’uccisione entro le 24 h dalla nascita è chiamata neonaticidio, l’infanticidio va dal primo giorno di vita al compimento del primo anno di età ed infine il termine figlicidio si utilizza per i bambini uccisi dal primo anno di vita in poi. Il motivo di questa distinzione sta proprio alla base della motivazione che porta a commettere il neonaticidio rispetto al figlicidio. Nel primo caso la principale motivazione è quella di impedire l’inizio della vita del feto, per lo più non voluto, e l’istaurarsi quindi di un legame affettivo. Nel secondo caso, invece, il rapporto è già iniziato e le motivazioni possono essere di gran lunga più numerose. Questa prima definizione criminologica sull’età funge anche come prima classificazione, ma presenta diverse limitazioni. Infatti, una suddivisione che si basa solo sull’età della vittima non permette di individuare gli eventuali fattori di rischio e di attuare strategie preventive. Esiste anche un’opinione che il rischio per un bambino di essere ucciso dai propri genitori diminuisce con l’aumentare della sua età. In altre parole, il bambino è più vulnerabile quando il rapporto madre-figlio non ha ancora raggiunto un legame solido e un solido attaccamento materno. Sicuramente bisogna prestare la massima attenzione sociale, in quanto la recrudescenza di episodi legati a figlicidi preoccupa oltremodo. Il recente fatto di cronaca riguardante una madre di 37 anni che ha abbandonato la figlia di 18 mesi a casa consapevole del rischio che correva per raggiungere il compagno rappresenta un campanello d’allarme fortemente preoccupante.
 Luigi Bernabò
Luigi Bernabò