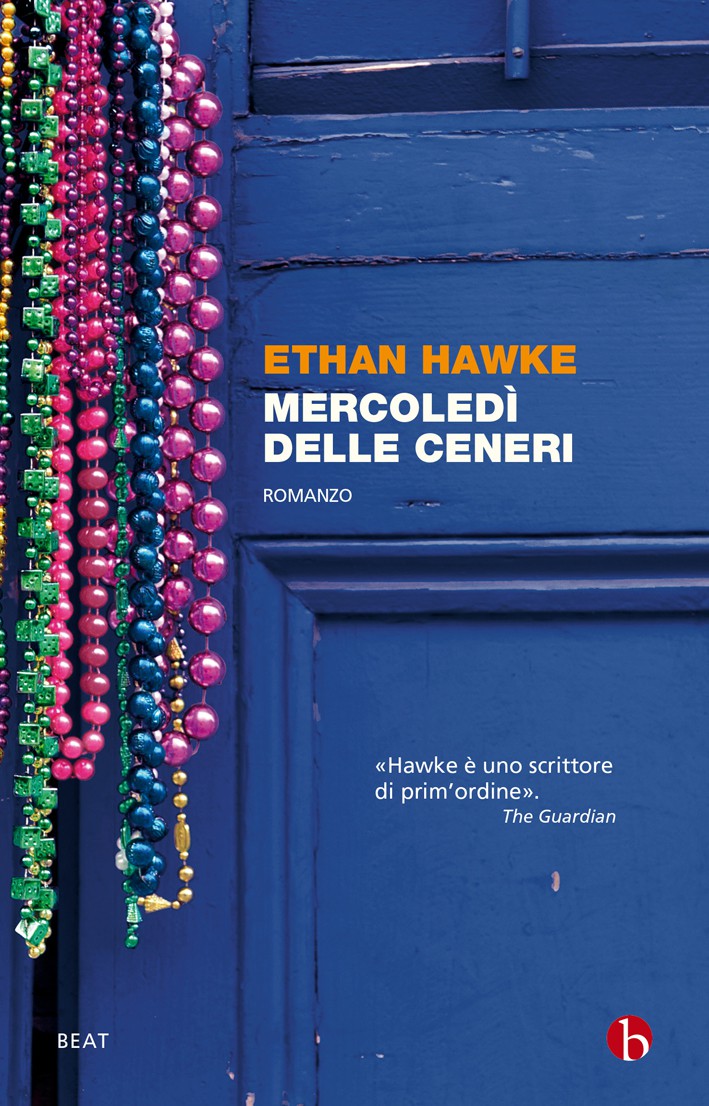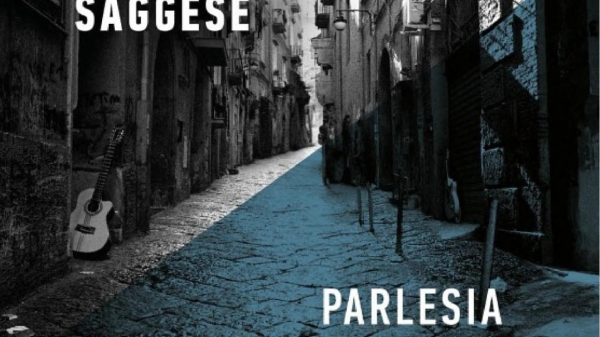Quella odierna è oramai, a pieno titolo, definibile come società “Smart”. Il ruolo del web è sempre più preponderante. Un luogo dove le persone sono sempre più interconnesse tra di loro e in grado di interagire da qualsiasi luogo e con velocità. I social network, per struttura e per devozione all’intero sistema, risultano essere la dimensione più affermata, sicuramente quella più diffusa tra la società. Oggi tutto – o quasi – è social. I dati forniti dall’agenzia “We Are Social” lasciano poco spazio all’interpretazione. Difatti, su circa 7 miliardi e 600 milioni di persone, 3 miliardi e mezzo sono attivi sui social media (Facebook da solo ne conta 2,5 miliardi). Il web ha mutato il tempo, ha permesso di rendere tutto “subito”. Le comunicazioni, le condivisioni e i risultati; tutto ciò rende la nostra vita frenetica, caratterizzata dalla concezione del “Hic et nunc”, portando al fatto che non sappiamo più aspettare, dimenticando le emozioni suscitate dall’attesa. Non sappiamo più cosa vuol dire attendere e non conosciamo più cosa si prova quando l’attesa termina. Siamo ormai parte di un sistema, di un concetto, di un modo di approcciare alla realtà che suona come un obbligo. Non si può prescindere da esso. Basti pensare alle nuove forme di marketing o di sponsorizzazione a vario titolo. Privati, aziende, associazioni, imprese, artisti (etc.) fondano la propria esistenza sulla dimensione social. L’uomo del nuovo millennio ha sviluppato una sorta di bulimia informativa che solo il web è in grado di assuefare. Dal gossip all’economia, dalla cultura allo sport, dalla medicina allo shopping, persino le relazioni interpersonali, in gran parte, oggi, hanno luogo su piattaforme social. Magari le comodità che esse sono in grado di garantire assurgono a concezione irrinunciabile per un uomo 3.0, ormai prono o forse, ancora, vittima della frenesia e pronto a sacrificare il dinamismo fisico in nome di uno smartphone inteso come cabina di gestione degli “affari” esistenziali. Col senno di poi, si potrebbe asserire che Stanley Kubrick in “Odissea nello spazio”, nel 1968, fu alquanto profetico nel rappresentare una società ipertecnologica senza immaginare, però, si potesse arrivare fino a questo punto.
 Mattia Tarallo
Mattia Tarallo