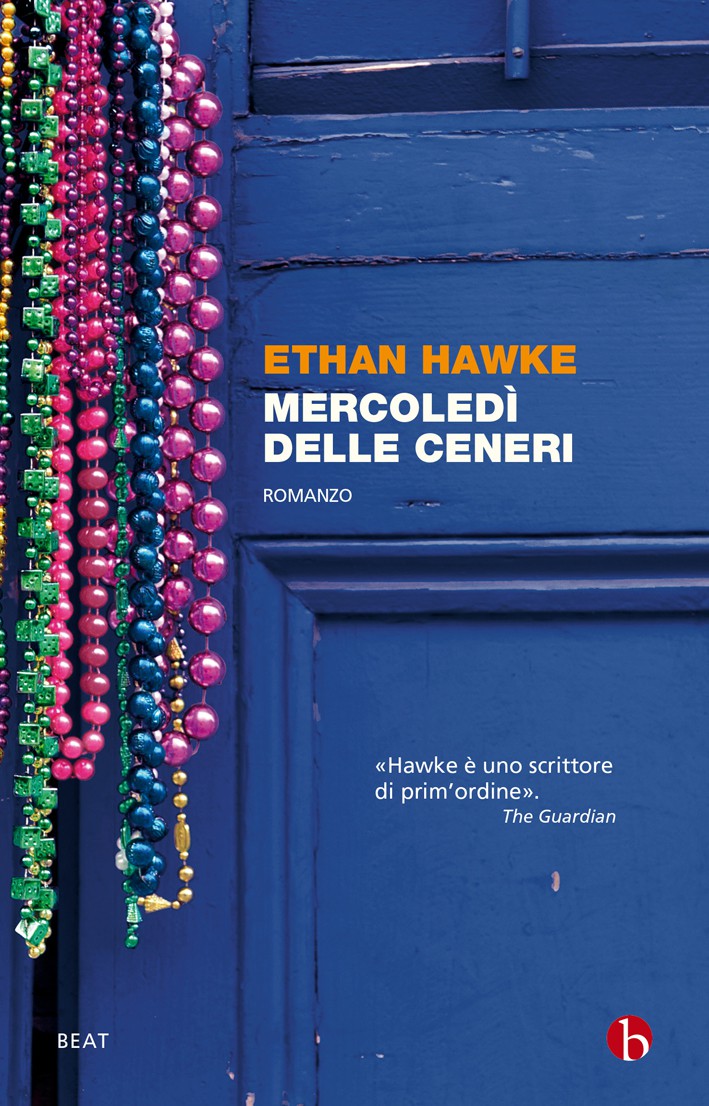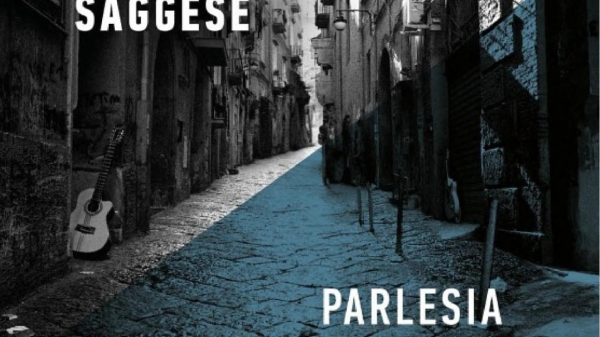Benché l’Italia, in una prospettiva comparativa, non sia un paese violento, la violenza di prossimità è un fenomeno molto diffuso e registra dati anche superiori alla media dei Paesi dell’Europa occidentale. Il caso Giffoni ha generato una grande attenzione per la drammatica dinamica di come avvenuto e necessita di riflessioni accurate ed attente. Fino ad oggi la sociologia ha utilizzato l’equazione potere-violenza per spiegare tali eventi. Il punto di partenza è la violenza contro le donne in ambito familiare che è stata portata alla luce dai movimenti di emancipazione femminile che, denunciando l’asimmetria dei ruoli attribuiti a uomo e donna nella società e nella famiglia italiana, spiegavano la violenza domestica come conseguenza del potere maschile. Negli anni ’70 tale spiegazione era plausibile, cinquant’anni dopo, essa trascura i cambiamenti avvenuti nella condizione della donna e nella parallela evoluzione dell’identità maschile. La violenza di genere è esercitata dagli uomini come classe al fine di mantenere i vantaggi che essi traggono dalla dominazione femminile. Ma il genere non è una classe. Tale impostazione non offre alcun vantaggio di tipo metodologico, ciò che dobbiamo spiegare non è perché gli uomini sono violenti, bensì perché e quando alcuni uomini lo sono. La famiglia patriarcale esiste ancora in Italia, e sicuramente la vicenda di Giffoni rappresenta questo modello, padre che impone le regole, moglie e figli succubi, ma non è l’unico prevalente modello familiare e neanche l’unico modello capace di generare violenza. Molte storie di violenza domestica e di violenza letale illustrano una situazione opposta e non rara, nella quale la donna è economicamente indipendente dal marito e avrebbe risorse economiche e personali sufficienti a mantenere se stessa e i figli. C’è da prendere in considerazione più modelli da osservare a cominciare dal livello microsociale dove osserviamo le situazioni specifiche e la dinamica interazionale tra aggressore e vittima. Osservata nel livello microsociale, cioè nello scambio uno difronte l’altro, la violenza nasce dentro un campo di forte tensione emotiva. Quando ricostruiamo il comportamento degli attori, e come nel contesto del caso Giffoni, costituito da più attori familiari partecipanti, moglie e figli, emozioni come la rabbia, la paura, l’umiliazione, la vergogna, la possessività, la frustrazione, insieme all’incapacità di controllarle, definiscono il confine nella quale ha luogo l’azione violenta. L’aggressione alla partner non è mai fredda, il conflitto, nelle diverse forme di scontro verbale, litigio, percosse, precede sempre in crescendo la furia finale. Ma conflitto e violenza sono fenomeni diversi e il conflitto è una condizione necessaria, ma non sufficiente di quest’ultima. Nelle storie di violenza di prossimità contro le donne, la letteratura scientifica propone due schemi di tale dinamica: l’assalto in preda alle emozioni e la routine di dominio violento. Nel primo tipo, il conflitto che esiste tra i partner cresce e viene gonfiato dalle emozioni, nasce da una discussione tipicamente per motivi futili o per gelosia, e si trasforma in conflitto aperto, urla, insulti e minacce, poi l’uomo passa a schiaffi e percosse contro la donna. La violenza fisica è un atto che accade alla fine di una sequenza temporale durante la quale c’è un crescendo di rabbia, frustrazione e paura. Non sempre l’atto violento è breve, ma è comunque più breve della sequenza precedente. Il secondo tipo di dinamica microsociale è stata chiamata routine di dominio violento o terrorismo intimo. Non nasce da un conflitto degenerante in un crescendo emotivo che travolge l’aggressore, è invece una dinamica perversa e duratura di controllo che lui esercita su di lei e spesso sui figli e che caratterizza la relazione. È una modalità istituzionalizzata dell’interazione, emotiva ma meno infuocata della precedente, perché la ripetitività tiene le emozioni degli attori entro un livello di guardia, un livello molto alto, ma conosciuto. La donna è il soggetto debole, l’uomo è l’aggressore, lei aderisce al ruolo della vittima, lui esercita la funzione di carnefice e nell’escalation come in questo caso sono coinvolti i figli, minori e non. Interrompere questa catena interazionale non è facile, si corre il rischio altissimo di recidiva. Questo approccio teorico evita il compito spesso infruttuoso di definire dapprima gli uomini violenti e le loro vittime. Se passiamo al livello superiore di osservazione, la domanda cruciale da porre è, a mio avviso, la seguente: chi è il soggetto debole e perché? La letteratura scientifica italiana assegna tale ruolo alla donna in base all’equazione potere-violenza. Ciò che rende deboli alcune donne sembra essere una forma di dipendenza dalla relazione. Una relazione conflittuale ed emotivamente troppo carica si può trasformare negli anni in una tortura quotidiana e concludersi in una tragedia, come avvenuto a Giffoni, in questo caso una reazione collettiva in quel nucleo familiare provato da anni di soprusi e privazioni. Ciò che, in queste situazioni, lega la vittima al suo carnefice non è il potere ma la dipendenza emotiva. Il potere non è forza bruta, questa è una definizione priva di alcun contenuto sociologico. Il potere è un attributo generato da una base di legittimità: il denaro, una posizione di rilievo occupata nella struttura sociale, un talento o personalità fuori dal comune o, nelle società tradizionali, l’età. In alcuni casi, gli aggressori sembrano invece reagire alla perdita di potere, a una crisi di status, reagiscono al conflitto con dosi di aggressività e violenza che sono tanto grandi quanto è fragile ed emotiva la loro maschilità. Esercitano controllo e forza fisica contro le donne, ma non potere. Se è vero che le definizioni di genere sono culturalmente fondate e che i due elementi della coppia maschile-femminile si definiscono anche per reciprocità l’uno verso l’altro, una parte del problema della violenza contro le donne sta nel fatto che il femminile italiano, cioè il ruolo, l’autorevolezza e lo spazio pubblico delle donne italiane è molto cambiato, mentre il maschile non altrettanto. Un limite serio degli studi italiani è che l’indagine si focalizza esclusivamente sulla vittima: la storia, la personalità, il vissuto della relazione, l’effetto non voluto di questa impostazione empirica è che l’evento sembra dipendere solo da lei. Nel livello micro abbiamo osservato la dinamica dell’uno difronte l’altro, nel livello meso dobbiamo porre attenzione ai ruoli ed alla variabilità dei modi in cui essi vengono rappresentati. La donna sottomessa non è solo la casalinga dipendente dal partner, molte storie di violenza mostrano che le radici della dipendenza stanno in un miscuglio di amore, sessualità, controllo e colpa. Inoltre, e non è certo secondario, gli studi sulla violenza devono incorporare nel campo di ricerca la spiegazione del maschile. Se, come detto, moltissimi degli uomini violenti e assassini sono incensurati e sani di mente, vi è un vuoto di significato che la spiegazione sociologica è chiamata a riempire con un profilo preciso dell’aggressore. La riflessione sul maschile e i suoi cambiamenti deve accompagnare la ricerca sul femminile. Le condizioni lavorative, la presenza dentro la famiglia, l’autorità degli uomini italiani sono cambiate moltissimo, in parte a causa dell’evoluzione femminile, in parte a causa di processi ancora più ampi, come la globalizzazione del mercato del lavoro, la caduta di prestigio di alcune professioni e la perdita di status delle classi medie. Fino a cinquant’anni fa, il principio di autorità era indiscutibilmente esercitato dall’uomo che occupava uno spazio centrale nella comunità, ma oggi le società affluenti sono società senza padre, comunità dove l’immagine del maschile rischia di diventare superflua in senso stretto, superflua ai fini della procreazione e del mantenimento della prole, e in senso metaforico, cioè ritenendo di poter fare a meno del principio di autorità, a prescindere da chi e come si eserciti. Questi mutamenti hanno trasformato non poco l’identità maschile minandone le antiche certezze. Il terzo livello di osservazione copre un campo molto ampio, la società, della quale posso solo ricordare alcuni elementi che mi sembrano importanti nella letteratura scientifica che riguarda la violenza. Il primo elemento che voglio ricordare è la comunità che sta intorno, in questo caso Curticelle, frazione di Giffoni Valle Piana, una comunità piccola, circoscritta dove ci si vede e ci si conosce più o meno tutti. Questo concetto ambiguo designa qui la famiglia allargata, gli amici e conoscenti, i vicini di casa e tutti coloro che, per rapporti personali o di vicinanza, sono legati all’aggressore e alla vittima. La ricerca scientifica e le politiche di intervento devono incorporare la dimensione della comunità, evitando di polarizzare l’attenzione solo sul rapporto vittima ed aggressori. Le politiche di prevenzione elaborate fino ad oggi in Italia, come le campagne stampa, centri antiviolenza, telefono rosa ed altro, hanno avuto il merito di abbassare la soglia di tolleranza alla violenza da parte della vittima, prova ne è che il numero di denunce è aumentato, ma non basta. Azioni devono essere intraprese per coinvolgere la comunità che sta intorno alla coppia, al nucleo familiare, anch’essa è parte della scena e potrebbe fare la differenza, quindi la Comunità di Giffoni Valle Piana dovrà dotarsi di strutture in grado di intercettare fenomeni di malessere all’interno dei nuclei familiari attraverso politiche sociali attente di ascolto e soprattutto di intervento. La negazione, il luogo comune di affermare non può accadere a noi, la rimozione, la stanchezza che proviene da un senso di impotenza, queste sono tutte forme di difesa elaborate dalla comunità che non aiutano o peggiorano la situazione. La comunità deve diventare una rete che tutela, aiutata dalle istituzioni, dalla scuola, dalle associazioni, dalle parrocchie per evitare che diventi un insieme casuale di individui che restano indifferenti gli uni verso gli altri. La comunità può tollerare ciò che avviene dentro le mura domestiche, seguendo la norma di rispetto delle vite private e può condannare ciò che accade apertamente, per strada, può evitare di intervenire in comportamenti privati e decidere di farlo per comportamenti pubblici. Per la ricerca sociale, è indispensabile comprendere come sono formulate queste definizioni e quando vengono impiegate. Il secondo elemento che voglio ricordare è quasi banale, ma al punto che deve essere rimesso in questione. La violenza di prossimità agisce all’interno di relazioni di amore o di amicizia. La categoria anonima partner o ex partner racchiude una storia degenerata di innamoramento, passione e intimità. Credo sia indispensabile interrogarsi su questa connessione. Che tipo di amore è quello che, almeno potenzialmente, può trasformarsi in tragedia? Nel livello microsociale abbiamo osservato la grande frequenza della gelosia, un sentimento che, unito ad altre emozioni forti, quasi sempre fa innescare la catena di interazioni che porta alla violenza. In dosi massicce, la gelosia è una follia condivisa da due che esprime possessività e desiderio di controllo. I due sono ripiegati su se stessi, le loro ansie non trovano sfogo esterno e pretendono che l’amore palesato in quella relazione escluda ogni altra relazione o bisogno. La dipendenza emotiva di lei può sostenere una relazione insopportabile, l’ossessione e la possessività di lui possono farne un carnefice. Cosa fare? Un primo elemento consiste nel cercare di mettere in luce con maggiore chiarezza le situazioni che generano violenza e la loro dinamica microsociale. La violenza domestica o di prossimità nasce da situazioni di conflitto continuo, molto aspro, duraturo e sovraccarico di emozioni, in tali situazioni, si manifesta con lo schema dell’assalto o della routine. Un secondo elemento riguarda la vittima, non si nasce vittima, ma si diventa quando ci si trova troppo a lungo in situazioni di dominazione. Non sempre la storia infantile e la personalità della vittima, tantomeno la povertà o il disagio sociale, ci consentono di spiegare la relazione violenta. Vi sono fasi e tappe della carriera di una vittima, più precisa sarà la ricostruzione di essa che deve includere una descrizione degli uomini violenti e delle reazioni della comunità intorno, più efficaci saranno le politiche di prevenzione. Il terzo elemento riguarda la possibilità di rivedere in modo critico alcuni concetti che la letteratura italiana utilizza in modo diffuso ma, oggi, poco consapevole, partendo dal fatto che la violenza è fisica, materiale, che può essere preceduta da insulti e aggressività verbale e accompagnata da manipolazione psicologica e ricatto, e che vi è una rete più o meno ampia di attori intorno alla coppia vittima-aggressore, e la ricerca sociale non deve concentrarsi solo su questa polarizzazione. Il corpo è il luogo primordiale di sintesi passiva della persona, il luogo per eccellenza del se medesimo e del sentire, sul quale si edificano le sintesi attive che sono l’esistenza e la responsabilità. Per questo il corpo offre agli altri la possibilità di una sua oggettivazione. La brutalità della violenza naturalizza la vittima, la riduce a oggetto dominato, cioè fissato dentro un modello rigido di identità, e riduce l’incertezza del pensiero intorno alle categorie che dovrebbero classificare e comprendere il corpo stesso e la persona. Infine, l’ultimo elemento che desidero ricordare è l’importanza delle azioni di prevenzione e cura verso la violenza di prossimità.
 Luigi Bernabò
Luigi Bernabò
Leggi QUI la copia digitale de Il Commendatore Magazine.