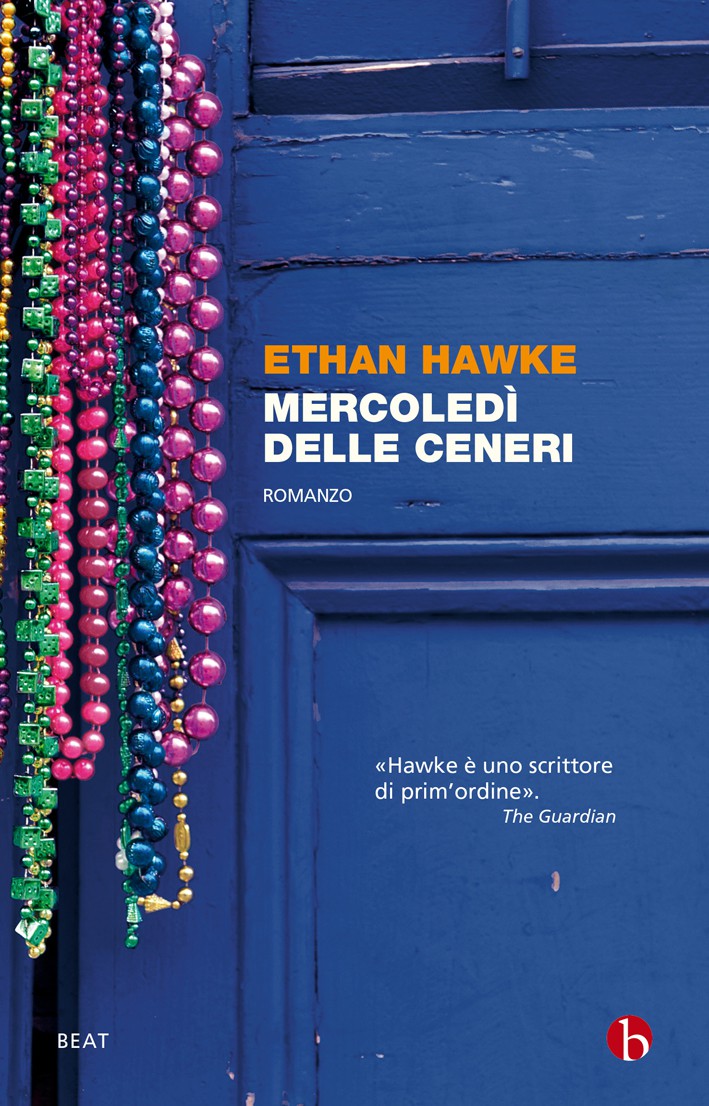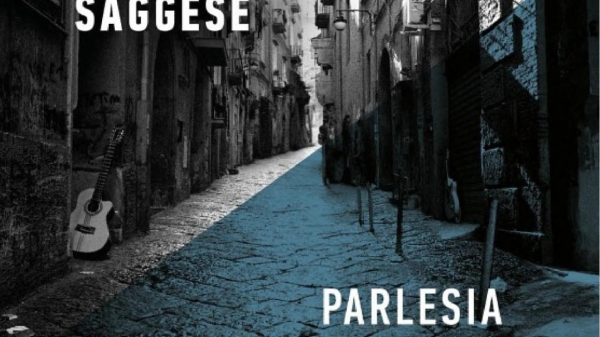Ve lo ricordate quando dai balconi urlavamo che ce l’avremmo fatta? Intonavamo a squarciagola e speranzosi canti popolari e nazionali, uniti nello spirito perché impossibilitati ad esserlo con i corpi? Eravamo tutti lì, uno al fianco dell’altro nelle videochiamate, ognuno nella sua finestrella, ma spalla a spalla. La sensazione diffusa, o meglio, la sensazione che ci piaceva (forse vergognandoci del contrario) far credere di provare era che il Virus (lo scrivo con la lettera maiuscola a rimarcare la pervasiva e ingombrante presenza che ha ormai nella vita di tutti) fosse giunto ex machina ad assolverci per le nostre colpe pregresse, a cancellare come un colpo di spugna le macchie della nostra condotta e a restituirci nuovi ad un futuro che ancora si prospettava più simile al passato che a un film di Terry Gilliam. Ci attendevamo, forse, o ci sembrava giusto millantare che, attraverso la ridefinizione delle priorità – la salute e la vita prima e al di sopra di ogni cosa – saremmo giunti alle soglie della purezza d’animo. E così, sedicenti filantropi, ci siamo indignati per i medici, le infermiere e gli infermieri impegnati a salvare vite umane senza sosta e senza protezioni sanitarie, ci siamo addolorati per i troppi morti, mai e dico mai troppo vecchi per continuare a vivere, quand’anche non fossero la parte produttiva del Paese, ci siamo assunti con orgoglio le nostre responsabilità civiche e i sacrifici fatti ci hanno fatto sentire persone migliori. Ma le aspirazioni di beatitudine sono state presto disilluse: le pose stoiche o zen, o da martiri (nei casi più estremi) della fase iniziale – non saprei dire se ci siamo raccontati frottole perché non essere altruisti e solidali in quei momenti sarebbe apparso quanto meno mostruoso alle coscienze delle donne e degli uomini tutti, o se davvero abbiamo creduto di stare evolvendo ad uno stadio superiore di civiltà – hanno lasciato posto ad istinti meno edificanti, dettati dalla paura, dall’isolamento, dal distanziamento, dalle perdite, e da nervosismo e depressione che ne sono seguiti. E vengo al punto: una pandemia non può essere catartica, anzi! E non solo perché ad un certo punto abbiamo smesso di cantare, abbiamo smesso di fare i selfie di gruppo su zoom e abbiamo riposto i tappetini del pilates. Non soltanto perché sono stati rispolverati atavici conflitti familiari – seppelliti dalla distanza chilometrica dei componenti e rinvigoriti dalla forzata convivenza imposta dal lockdown – e si sono palesate le crisi di coppia messe a tacere dal fluire rumoroso e abitudinario delle esistenze a due. Non è bastato l’aggravarsi di forme di depressione latente di chi ha percepito il dilagare del contagio come lo spegnersi delle luci sul futuro. Non era abbastanza l’inesorabile peggiorare delle disuguaglianze sociali: sempre più poveri i poveri e sempre più deboli i deboli. Nemmeno l’aumento della percentuale di separazioni e divorzi è stata la cosa peggiore del risveglio dal torpore mistico da cui per un po’ siamo stati anestetizzati. Statistica peggiore della suddetta, si sono tristemente intensificate le violenze tra le mura domestiche, ovviamente per lo più quelle di uomini a danno di donne. Sono più che raddoppiate tra marzo e giugno 2020 le telefonate al numero verde promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità, destinato ad accogliere le richieste di aiuto delle vittime di violenza e stalking. E allora viene da chiedersi in che cosa siamo cambiati. A chi e a che cosa ha fatto bene la pandemia? Quali ne sono stati gli effetti se non l’acuirsi della nostra già spiccata autoreferenzialità, della nostra visione univoca e monolitica delle cose, per non dire egoistica, cocciuta e orba? Il Covid-19 ci ha reso semplicemente quelli che siamo, che già eravamo e che ancora saremo, perché ce la caveremo. Non può mondare ciò che è immondo se era di questo che ci eravamo illusi. Dobbiamo solo avere fiducia nella scienza e sperare che passi presto facendo la nostra parte. Se non le avessero bruciate sul rogo ci avrebbero pensato loro.
 Enrica Colasanto
Enrica Colasanto