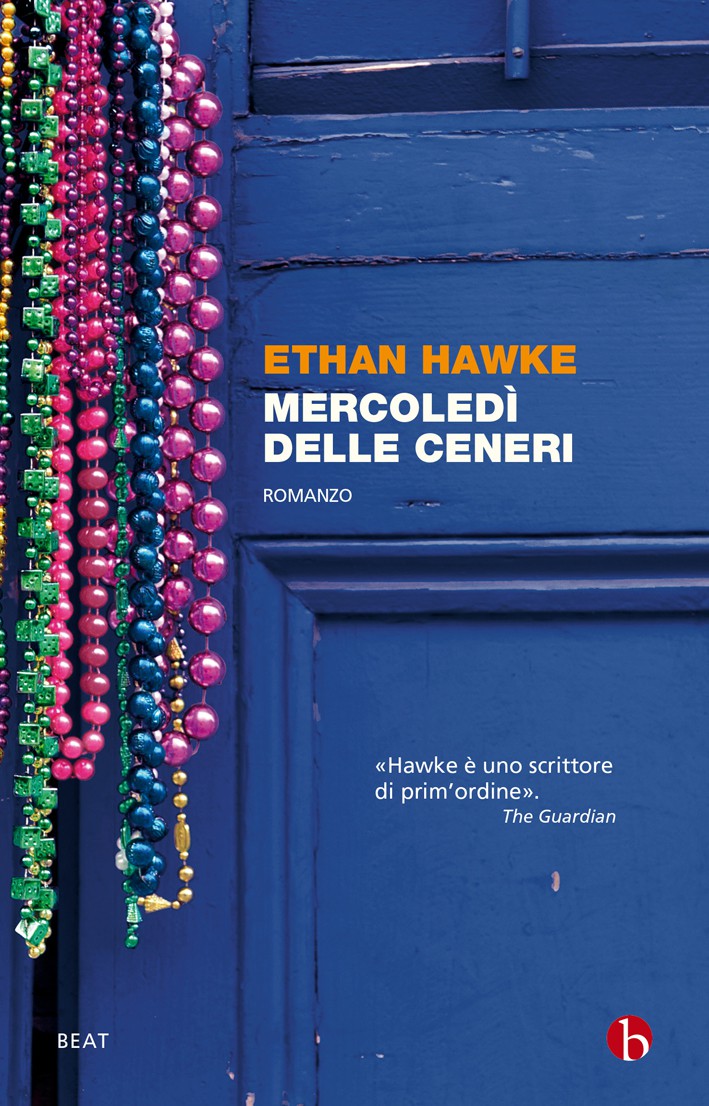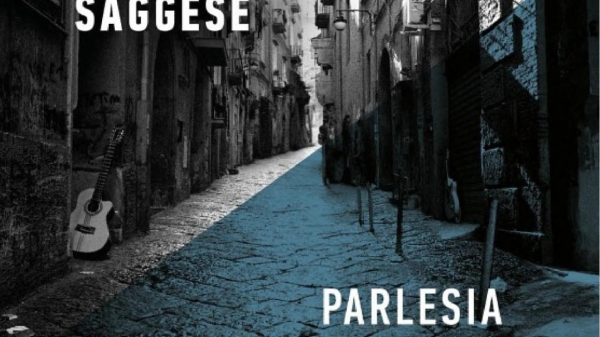Ognjen Spahic è nato a Podgorica, Montenegro nel 1977. Dopo aver studiato Ingegneria civile e Filosofia si dedica a tempo pieno alla letteratura e in breve tempo diventa il più noto tra i giovani narratori montenegrini. Autore di due raccolte di racconti e del romanzo che propongo questo mese, I figli di Hansen (Zandonai Editore, 13.50 euro), tradotto in inglese, spagnolo e francese. Partendo dal titolo, I figli di Hansen, che sono i malati di lebbra: dal cognome del dermatologo norvegese Gerhard Armauer Hansen, che identificò il batterio Mycobacterium leprae nel 1873. L’ambientazione della storia quindi è l’ultimo lebbrosario d’Europa, sperduto nelle campagne rumene nei pressi della foce del Danubio. Il periodo storico in cui si svolge sono gli ultimi mesi della feroce dittatura di Ceausescu, dalla primavera alla caduta. Ma tengo a precisare che non è un romanzo storico (anche se alcuni salti nel passato servono a darci informazioni della lebbra in alcune epoche) ma la cornice angosciante per una storia disturbante, malata. Infatti l’autore disegna l’architettura di questo progetto ambizioso partendo dal nucleo, dal piccolo: dall’invisibile batterio che deforma il corpo e lo spirito dell’uomo, rinchiusi, se non detenuti, dentro un lebbrosario alla fine del mondo, nei recinti di una dittatura. L’io narrante, nella prima parte del romanzo, ci accompagna nel quotidiano di questi undici uomini facendo un focus dell’edificio/prigione in cui vivono. Poi invece si scende inesorabilmente faccia a faccia con la malattia, prima in un flusso introspettivo e spirituale e di conseguenza il dettaglio (in alcuni punti davvero disturbante) su cosa provoca la lebbra sul corpo. Un foro da cui arriva la luce però c’è, ed è l’amicizia tra il protagonista (io narrante) e il suo compagno di cella/camera. Il vero fil rouge che mantiene in tensione la storia. Dalla seconda parte il romanzo cambia registro e viene fuori di più la parte tecnica e strutturata del racconto, la trama, che segue la sua linea senza intoppi, evoluzione anche troppo rigida secondo me, ma affidabile fino alla fine. Chiudo, come sempre, con un estratto augurandovi una buona lettura.
Ho sempre l’impressione che al nostro edificio e al suo stretto circondario si guardasse come a un vecchio e maledetto cimitero nel quale si aggirano gli spettri, e non come a un istituto di cura. Credo che a ciò abbiano contribuito le lunghe mantelle che indossiamo, indispensabili protezioni dal sole e dagli sguardi degli altri malati. O almeno da quelli di coloro che gli occhi ancora li avevano.
 Mario Terlizzi
Mario Terlizzi