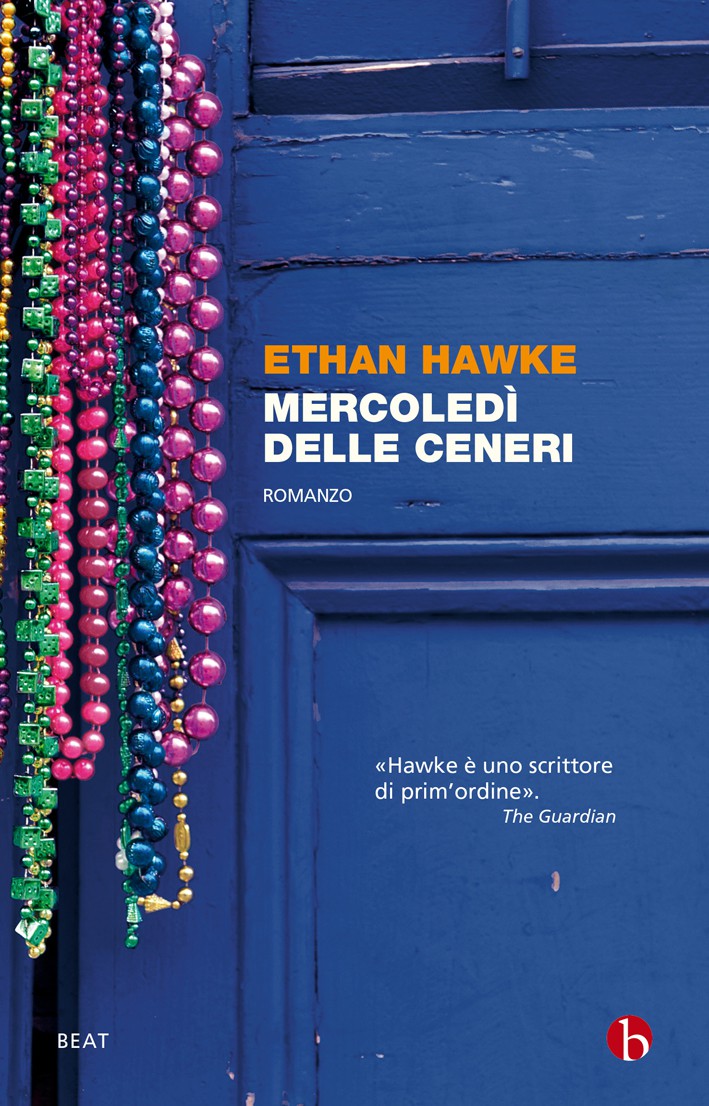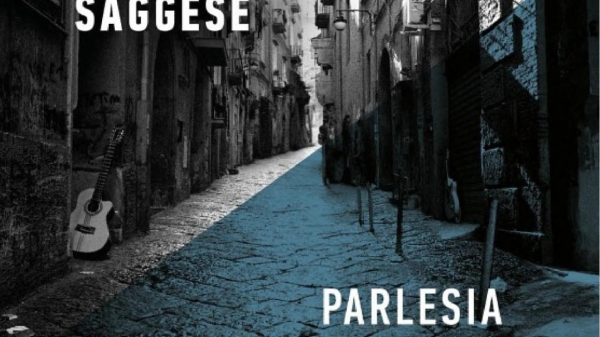Di qualche mese fa è la notizia dell’ennesimo deplorevole episodio di revenge porn. Il processo ha inizio nel novembre del 2020 e la vittima è una maestra d’asilo di una scuola del torinese. Nella primavera del 2018, il suo ex ragazzo diffonde un video che li ritrae in un contesto di intimità e che viene condiviso nella chat whatsapp del calcetto. Un membro del gruppo è anche il padre di una bambina che frequenta l’asilo della maestra e il filmato arriva anche agli altri genitori ed infine alla dirigente scolastica. Invece della dovuta difesa e solidarietà, l’insegnante subisce lo stigma della comunità scolastica, genitori e colleghi insieme. Non solo: come ritenuta colpevole di qualcosa, la maestra è costretta a dimettersi. Fortunatamente, vi è un seguito. La maestra denuncia la violenza subìta. Il magistrato ha chiesto due condanne: 12 mesi per la mamma di una bambina che avrebbe indebitamente diffuso foto e video nelle chat dei genitori e 14 mesi per la direttrice dell’asilo privato che l’avrebbe costretta alle dimissioni e che, secondo una ricostruzione dell’accusa, avrebbe espresso il timore che i genitori ritirassero i propri figli dall’istituto. La vicenda palesa dinamiche sociali tristemente radicate: maschilismo, sessismo, sessuofobia. Nei gesti dei coinvolti (come in molti dei commenti suscitati dalla notizia) è evidente l’opinione che è lei che ha sbagliato ad inviare foto e video, lei si deve vergognare per il fatto che tutti abbiano visto. Il ruolo da lei ricoperto implicherebbe quasi, nell’immaginario dei benpensanti, l’astensione dal sexting e forse anche dal sesso. Sexting e sesso sarebbero la colpa, più della diffusione non autorizzata di immagini intime altrui. Una maestra, una che educa non può permettersi di avere desideri sessuali, né tanto meno di appagarli: è grande la mancanza di un’educazione sessuale nelle scuole e in altri ambienti. Ma colpisce anche l’assenza di empatia, di comprensione, di capacità di immedesimazione. E allora tra le cose che servono c’è sicuramente anche l’educazione all’affettività. C’è però un altro aspetto della vicenda, che riguarda questa come altre, ed è la reciproca ingerenza tra sfera pubblica e privata. Nell’Atene del V secolo a.C. la dimensione pubblica dei cittadini (ça va sans dire: maschi adulti liberi che avessero completato l’addestramento militare) era precipua rispetto a quella privata. Partecipare alla democrazia non era solo un diritto, era soprattutto un dovere di chi era membro dell’assemblea (ἐκκλησία) che legiferava o di chi ricopriva cariche pubbliche. Essere cittadino significava contribuire a garantire un modello politico che era essenziale all’imperialismo di Atene (di cui in qualche modo beneficiavano tutti gli abitanti della πόλις di Pericle). Esercitare le proprie funzioni pubbliche in una democrazia diretta come quella ateniese implicava senz’altro anche il coinvolgimento di energie private tese al mantenimento del sistema. Difficile stabilire quanto in termini di integrità morale (se di questa è possibile parlare senza incappare nella manifestazione più o meno velata di retaggi culturali) fosse richiesto ai fautori di quella singolare forma di governo. Da allora è passato qualche secolo e di certo non è assimilabile quel contesto politico alle moderne democrazie, quelle che conosciamo noi e nelle quali esprimendo il nostro voto eleggiamo i nostri rappresentanti. Sicuramente però, per il mondo occidentale, la sfera pubblica è ancora centrale nella vita degli uomini (e, purtroppo in minor misura, delle donne). La tendenza attuale sembra essere quella di una distinzione tra ciò che si fa e si è in quanto esponenti del tal dei tali ambiti pubblici e ciò che si fa e si è con i propri familiari e amici, in contesti intimi e privati. E per quale motivo? Sembra c’entrare poco la riservatezza e tanto meno la privacy nel riserbo con cui si vive la propria personale esistenza. La necessità di dividere in due la propria vita nasce dal frequente insorgere di questioni etiche: “sta bene” o “non sta bene”. Alcune addirittura paiono questioni di banale decoro (termine che appartiene a chi ne fa un criterio di ammissibilità, non a me). Sovviene a chi scrive il caso di Piero Marrazzo, dimessosi nel 2009 dalla carica di Presidente della Regione Lazio non per aver commesso un reato, ma perché ne furono rese pubbliche le private abitudini. Non so che amministratore fosse Marrazzo, ma non credo che la sua bontà di governatore di regione dipendesse da come trascorreva le sue serate, finito di lavorare. Ma davvero le scelte fatte per sé stessi possono entrare in contrasto con ciò che si fa per gli altri? Perché mai la vita sessuale di una maestra potrebbe essere un cattivo esempio per i suoi alunni che ne sono messi a parte contro la volontà di lei? E come può essere un buon esempio educativo un padre che diffonde, non autorizzato, le foto intime di un’altra persona? Dove è finita la logica? La scelta prediletta delle potenziali vittime di scandalo è quella dell’occultamento ipocrita e a volte maldestro dei propri gusti e desideri. Forse perché non c’è categoria più inclemente degli scandalizzati, di quelli che coprono le bocche spalancate con entrambi i palmi delle mani, bloccando gemiti di stupore e compiacimento per la propria persona. Sono quelli a cui piacerebbe fare una bella tirata di orecchi o una bella ramanzina a chi si è perso e sono quelli che hanno bisogno dell’educazione all’affettività (o di una bacchettata di strega sulle mani).
 Enrica Colasanto
Enrica Colasanto