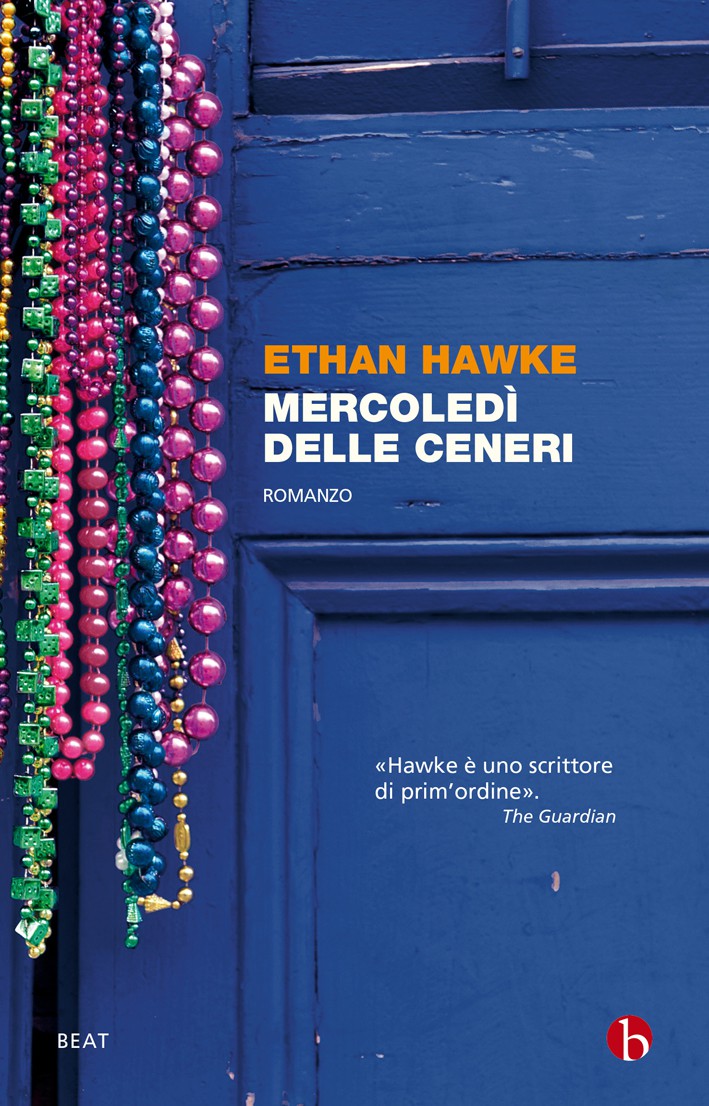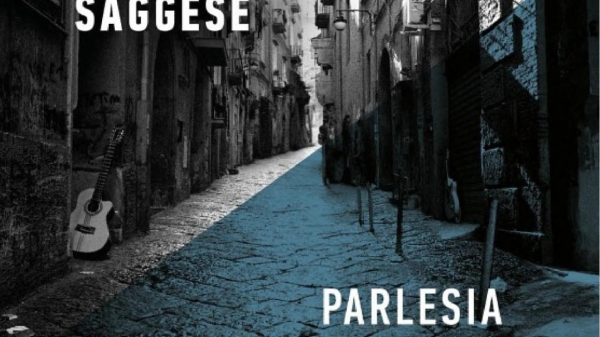Il 15 ottobre 2009 Stefano Cucchi, geometra italiano, viene fermato dai Carabinieri dopo essere stato visto cedere a Emanuele Mancini delle confezioni trasparenti in cambio di una banconota. Portato in caserma, viene perquisito e trovato in possesso di 12 confezioni di hashish, tre confezioni impacchettate di cocaina, una pasticca di un medicinale, dato che l’uomo soffriva di epilessia. Viene disposto l’arresto nei suoi confronti. Il giorno dopo si tiene l’udienza per la conferma della custodia cautelare: durante il processo Stefano Cucchi ha difficoltà a camminare e a parlare e mostra evidenti ematomi agli occhi. Nonostante le precarie condizioni, il giudice conferma la custodia cautelare al carcere di Regina Coeli. Le testimonianze raccolte parlano di lesioni e percosse che Stefano Cucchi avrebbe subito dai Carabinieri la notte dell’arresto. In carcere le sue condizioni peggiorano ulteriormente: dopo una settimana dal suo arresto, Stefano Cucchi muore per lesioni ed ecchimosi alle gambe, al viso, una frattura alla mascella, all’addome, un’emorragia alla vescica, al torace, due fratture alla colonna vertebrale. Di fronte a una così triste vicenda che ha trovato ristoro con la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado solo nel 2019, viene da chiedersi: “Come sia possibile che una persona, che si trovi in stato di arresto, possa morire per mano degli stessi Carabinieri che, invece, avrebbero dovuto tutelarlo? In questo caso è evidente che sia stato del tutto violato il diritto di difesa, il quale è un diritto inalienabile della persona tutelato prima di tutto dalla Costituzione: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi legittimi. La difesa è un diritto inalienabile in ogni stato e grado del procedimento”. (Art.24 Cost.) Da ciò si evince che questo diritto debba essere riconosciuto nei confronti di ogni cittadino, sia che si tratti di una persona arrestata sia che si tratti di una persona imputata in un processo penale. Tuttavia, Stefano Cucchi è stato privato di questo diritto. Privato del suo diritto di conoscere le accuse che gli venivano sollevate, di essere informato sul fatto contestato, di nominare uno o due difensori o di essere assistito, in mancanza, di un difensore di ufficio e di conferire con il proprio avvocato. Ovviamente, tutto questo ha una sua ratio: dal momento che il nostro sistema giudiziario è fortemente garantista, non è possibile che una persona venga indagata e processata senza avere la piena e precisa consapevolezza delle accuse che le siano state rivolte. Lo scopo di questo sistema è molto chiaro: porre la persona indagata o imputata nelle condizioni di conoscere i reati contestati e, di conseguenza, poter esperire la migliore difesa possibile. Ma perché è stato possibile, da parte delle forze dell’ordine, insabbiare la vicenda? Ciò è senz’altro dovuto a una lacuna normativa: il legislatore nel disciplinare il reato di tortura (art.613bis c.p.), è incorso in due evidenti limiti applicativi. Il primo è che non risulta configurato come un reato proprio del pubblico ufficiale, ma come un reato comune, nonostante la maggior parte dei casi di tortura siano realizzati da un pubblico ufficiale. Il secondo è che questa norma si applica solo alle persone già private della libertà personale e non anche alle altre, creando un’evidente disparità di trattamento. Auspicabile è, pertanto, l’intervento del legislatore al fine di colmare gli attuali vuoti normativi, in modo da consentire un’applicazione maggiormente paritaria della normativa e garantire a tutti l’accesso ai propri diritti.
 Valentina Cicatiello
Valentina Cicatiello
Per approfondimenti, inchieste ed opinioni, clicca sulla scritta in basso.
Leggi la copia digitale de Il Commendatore Magazine.